 |

|  |
 |
 |
|
A):Processo
combinatorio
|
|||
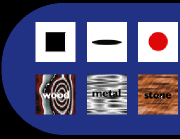 |
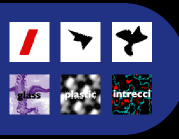 |
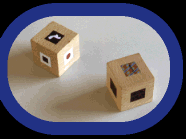 |
|
Codice
delle dimensioni
Il tema della
progettazione ricondotto alla scelta di elementi volumetrici caratterizzati
da singole dimensioni (x,z,y) estremizzate positivamente o negativamente
(o grandi o piccole).
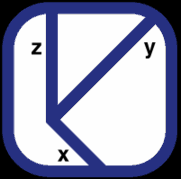
Il codice
delle dimensioni
è
un sistema di campionamento degli oggetti dal punto di vista del loro
rapporto dimensionale interno. L'estremizzazione dei singoli valori delle
coordinate cartesiane x, z, y in un " + ", cui corrisponde un
valore alto, o in un " – " cui corrisponde un valore basso,
è il primo assioma che permette di sintetizzare in una terna di
valori positivi o negativi, l'aspetto formale degli oggetti. Questa estremizzazione
separa dunque alcuni oggetti da altri attraverso un codice identificativo
dalle caratteristiche definite, senza ambiguità.
Ad esempio oggetti in cui prevale l'altezza in maniera evidente sulle
altre dimensioni sono contrassegnati da un ( - + - ), oggetti in cui sono
prevalenti la x e la z , ossia la larghezza e l'altezza, saranno ( + +
- ), ( un muro ad esempio che si erge come un ostacolo).
L'insieme
degli oggetti che si evidenziano grazie a questo codice costituisce un
abaco di elementi chiari, utili per composizioni in cui la riconoscibilità
di ogni elemento è legata all'evidenza del rapporto dimensionale
interno.
Questo non è l’unico dato per cui gli oggetti risultano riconoscibili
alla percezione, in quanto anche altre categorie sono qualificanti: materiale,
colore, funzione, peso etc.: questo processo però interessa unicamente
l'aspetto formale geometrico interno agli oggetti escludendo perfino il
rapporto proporzionale relativo, legato cioè alla misura globale
e alla scala oggettiva: una volta dato il codice, gli oggetti perdono
il rapporto relazionale di misura: gli oggetti diventano relazionabili
soltanto in funzione dell'astratto codice dimensionale interno.
Una
lettura della realtà attraverso questa classificazione esclusiva
lascia fuori gli elementi la cui natura dimensionale non è così
ben delineata: sono infatti eliminate le misure intermedie, che non possono
marcare gli elementi identificandoli nei loro estremi dimensionali. Diventano
così identificati un cipresso o un foglio di carta, perché
il loro codice dimensionale è facilmente registrabile: ( - + -
) per il primo, ( + - + ) il secondo, e dunque possono legarsi in un sistema
più o meno equilibrato secondo il parametro compositivo che verrà
esposto più avanti. Sono meno identificabili oggetti che non assumono
forme nette o approssimabili a volumi semplici, oppure oggetti in cui
la differenza tra le dimensioni interne non è evidente. Anche tra
questi ultimi può esistere un codice di appartenenza legata ad
una classe funzionale: sono elementi approssimabili a cubi o a sfere che
a seconda dell'uso nel reale o figurato nella composizione, possono registrarsi
come ( + + + ) o ( - - - ). Quest'ultimo caso comprende tutti gli oggetti
cui viene dato il compito di riferimento visivo primario (es.: un monumento
in una piazza).
L'identificazione
tipologica si determina anche in base alla posizione dell'oggetto nello
spazio: rimanda ad una relazione tra gli oggetti in funzione di una logica
compositiva di cui lo spazio è campo di assemblaggio definito.
Si può prendere una matita, che in base alla sua posizione nello
spazio assume il codice ( + - - ), ( - + - ) o ( - - + ) e fissare una
di queste terne in funzione di una ipotesi compositiva in un sistema a
più elementi.
Dall’analisi
delle terne elencate emergono alcuni elementi interessanti:
a) esiste un ovvio legame tra l’elemento
( - - - ) e l’elemento ( + + + );
b) questi due, oltre agli elementi ( + -
+ ) e ( - + - ) sono indifferenti all’orientamento determinato dalla
posizione dell’osservatore sul piano orizzontale di riferimento:
il loro codice è simmetrico;
c) gli altri elementi, contrassegnati da
un codice asimmetrico, risentono dell’ orientamento determinato dall’osservatore
sul piano: essi possono invertire gli estremi in funzione dell’ orientamento
delle coordinate cartesiane x e z ed un ( + + - ) può diventare
un ( - - + ).
La
catena di elementi genera un tracciato in progressione ortogonale la cui
origine è contenuta già nella condizione identificativa
degli elementi sulla base degli assi cartesiani. Esso viene assunto come
riferimento di un ordine archetipo. L'assemblaggio si trasforma in una
composizione quando ad esso viene dato l’orientamento in base alla
posizione di osservazione e un obiettivo di resa globale.
Il punto di vista dell’osservatore pone una condizione identificativa
inalterabile per tutto il sistema: esso determina l'orientamento e quindi
il codice identificativo degli oggetti.
Il procedimento consiste dunque nell'individuazione di elementi identificabili
per caratteristiche dimensionali, nella loro classificazione e nell'assemblaggio
in catene, in insiemi chiari, caratterizzati da un unico registro ortogonale
e da una logica interpretativa.
Gli
oggetti selezionati come referenti del potenziale geometrico descritto,
rimangono portatori di una serie di elementi essenziali per la qualità
dell'assemblaggio: materiale, levigatezza, definizione intrinseca, rapporto
forma/funzione, oltre alla carica simbolica aggiunta delle associazioni
possibili.
Una concatenazione di due o più oggetti si può riassumere
in un elenco di terne di valori di dimensioni x, z, y la cui sommatoria
verifica più situazioni:
> di equilibrio esatto, nel caso che in
tutte le dimensioni il risultato algebrico sia zero (è il caso
del cipresso e del foglio di carta);
> di equilibrio + o equilibrio - , nel
caso nella sommatoria delle x, delle z, delle y permanga per tutti un
segno + o un segno - (il caso precedente cui si aggiunga o un grande volume
o un concentratore);
> di prevalenza x, z, o y, nel caso di
che la sommatoria delle dimensioni risulti con un + soltanto in una coordinata.
Una
conseguenza del processo risiede nella possibilità di equilibrare
un insieme aggiungendo uno o più oggetti in funzione delle necessità
desumibili dalle sommatorie, oppure verificare come alcuni assemblaggi
di elementi riscontrabili in composizioni architettoniche storicamente
note riconducano a sistemi più o meno equilibrati (es. la piazza
del Campidoglio di Michelangelo).
Il
codice delle dimensioni è strumento di progettazione o verifica
progettuale che si fonda su una condizione archetipica di soddisfazione
percettiva (es. obelisco in una piazza). La classificazione in elementi
piccoli, stretti e piani, vasti, alti o grandi coincide con le principali
semi lavorazioni dei materiali (il metallo per esempio: piccole fusioni,
lastre, coils, profilati, grandi fusioni) e comunque in esso è
possibile rintracciare gli elementi costitutivi di base di ogni costruzione
umana.